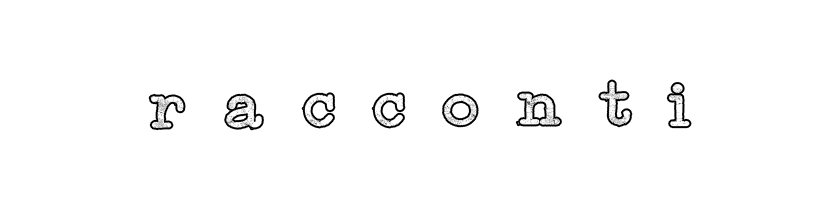La motonave
Era sera, il capitano mi aveva piazzato di piantone all’ingresso della camerata che si trovava all’unico piano dello stabile infuocato. Poche finestre alle pareti e da lì neanche si vedeva il mare, ma solo altri alloggiamenti. Salendo sul tetto, il panorama non cambiava, anche arrampicandomi su una qualsiasi cisterna d’acqua lassù ubicata avrei visto solo il cielo.
Il solaio era fatiscente, coperto di sabbia mista al catrame che fuoriusciva come se fosse lava nera. Gli scarponcini vi si lordavano sempre, appiccicandosi a quella melma che poi si induriva.
La “disposizione” era che dovevo star in piedi fuori dalla porta per un’ora, ma spesso mi sedevo su una pietra, per poi ritornare in branda a riposarmi per centoventi minuti. Ventiquattr’ore di servizio massacranti perché noiosi. Mi sfinivo. Un attimo di sonno e già mi dovevo alzare. Fare il piantone o la sentinella in quel posto non serviva a niente e a nessuno. Il complesso era circondato da alte mura di tufo rosso o materiale simile, che cazzo ne so, non ero un muratore. Era solo una punizione individuale.
Di notte faceva freddo in quella regione e di giorno si moriva di caldo. Il tempo non passava mai, non sapevo come impiegarlo. Potevo solo contare le grosse formiche che facevano la spola dalla loro buca a un’altra. Col pugnale in dotazione cercavo di puntarle e ucciderne qualcuna. Dovevo pur occupare quelle ore. Ogni tanto ne beccavo una, ma ero scarso. Poi arrivava Mohamed, che io chiamavo semplicemente “Negro”, veniva a darmi il cambio. Una rapida conversazione, due battute con qualche frase tipo “ne hai ammazzate?”, e io “sì, ma poche, adesso divertiti tu”. Era il suo turno. Il tunisino parlava francese, arabo, la mia lingua, qualche dialetto berbero, ma non era per niente un “barbaro”, anzi, un ragazzo molto fine, affidabile, intelligente, però fumava sigarette così puzzolenti che impestavano pure chi gli stava attorno. Era islamico ma non gliene fregava niente della religione, recitava. Gli piacevano le femmine occidentali, ma lì non ce ne stavano, lì non c’era niente, solo il deserto, infinito e silenzioso, che ci separava dalla “civiltà”. Adorava la carne, le costate, la salsiccia, ogni parte del maiale. Era uno dei pochi amici. Un giorno, finalmente, avremmo cenato insieme in tre, io lui e il porco. E così poi avvenne per vari anni.
Guardando l’orologio mi accorsi che erano le tre di notte, mancava ancora un po’ all’alba ma non me ne fregava niente, ero stanco, osservavo il cielo, le formiche erano scomparse, forse dormivano, beate loro, il silenzio mi ottundeva. Mi appisolai, come sempre, facilmente. Una bastonata in testa o un colpo col calcio di fucile mi stroncarono, e mi trovai cosciente per terra per qualche frazione di secondo. Poi mi risvegliai in un letto a castello in una stanza che sembrava un’enorme cabina di una nave. Lentamente mi accorsi che si trattava davvero di un’imbarcazione. Sentivo il rumore di grossi motori, assordanti, un’oscillazione ondeggiata simile a quella di un grosso mostro che flotta in un mare agitato.
La cabina sembrava una cella. Non c’erano oblò, ma solo una porta stagna chiusa di fronte a me, senza chiavi, senza maniglie. Era l’unica uscita da una prigione semovente.
Avevo fame, sete e dovevo pisciare. Lì dentro non c’erano toilette, vettovaglie, neanche una bottiglietta d’acqua. Il beccheggio della nave era esagerato. Spesso si alternava al rollio, in ogni caso non riuscivo a tenermi in equilibrio. Lentamente, per non finire a terra, raggiunsi barcollando quella porta. Non era provvista di maniglie o altro, e il volantino era ovviamente nel corridoio esterno alla “mia” camera. Cominciai a bussare, battendo i pugni su quel varco d’acciaio. Lo volevo sfondare, ma sarebbe stato impossibile. Nessuno mi rispose. Nella cella con me non c’era anima viva. Era enorme, avrebbe potuto ospitare trenta cristiani. Andai in un angolo, diedi un’occhiata in giro e vidi una telecamera seminascosta sul tetto. L’osservai, alzai il dito medio in segno di “saluto internazionale”, tirai fuori l’uccello e mi rilassai nello svuotamento di una saturazione che sembrava dolore che si trasformava in estasi.
Dopo qualche secondo, la porta si aprì e diversi militari in un’uniforme sconosciuta mi si fecero contro correndo. Ne atterrai un paio con rapidi pugni in faccia, uno lo afferrai per il collo cercando di strangolarlo tra avambraccio e bicipite, ma gli altri mi colpirono in ogni parte del corpo con pugni, testate, e mi sminchiarono. Non so che giorno fosse, se all’esterno l’oscurità o il sole, ma mi svegliai con tutte le ossa rotte, non riuscivo ad aprire un occhio, la schiena era a pezzi, le costole doloranti. Provai ad alzarmi ma mi faceva male il petto, probabilmente mi avevano rotto una costola o più di una (in realtà poi seppi che erano due). Cercai lo stesso di rialzarmi e voltandomi a sinistra verso il pavimento vidi una cassa d’acqua e una baguette poggiata sul pavimento lordo. Non ce l’avrei fatta mai a raggiungerli. Avevo fame, sete e spasimi lancinanti. Sforzandomi, lentamente, mi posizionai su un fianco, poggiai le braccia per terra, muovendomi come un serpente, e poi caddi vicino al panino. Prima di tutto bevvi, e quell’acqua si trascinò in pancia quel qualcosa che in bocca aveva avuto il sapore del sangue. Acchiappai quella leccornia farcita di formaggio tagliato a fette e mangiai lentamente come se fossi un uccellino. Dalla posizione prona passai a quella supina, con una fatica straordinaria. Guardai la parte superiore della cella e mi rilassai. Vidi la telecamera, probabilmente mi stavano monitorando. Alzai la testa pian piano da terra e mimai con una mano il taglio della gola. Poi farfugliai un “io vi ammazzo”, sorrisi, ed espirai dolore.
La stanchezza, il sonno e le ferite mi avevano estenuato e chetato, e quindi mi ero proprio addormentato. Avevo la guancia sinistra poggiata per terra e guardavo di sbieco verso una parete oltrepassando col mio sguardo la parte sottostante i letti a castello. Vidi solo batuffoli di polvere lanosa, lordume in sintesi. Mi sforzai di alzarmi e ci riuscii. A terra si estendeva una chiazza di sangue, molto liquida, mista ad acqua. Mi toccai la bocca con le dita, e guardandoli notai che qualche lacerazione interna faceva scorrere fiele amaranto.
D’un tratto sentii la porta aprirsi, uomini entrare nella stanza, ma io non avevo la forza per voltarmi. Alcuni mi avvinghiarono la testa immobilizzandola, altri mi presero i piedi (ero scalzo) torcendomi gli alluci, finché non smisi di agitarmi. Mi trascinarono fuori come una bestia da portare al macello. Il corridoio era lungo e silenzioso. Finalmente “arrivammo” in una celletta, mi bloccarono al pavimento. Un lurido bastardo mi teneva uno scarponcino sul collo schiacciandomi sul pavimento, altre scarpe e mani mi arrestavano gli arti inferiori, e qualcuno “intelligente” mi chiuse gli occhi con le dita sprofondandomeli con una pressione da far svenire. Appena furono sicuri che non potessi muovermi, una “specie” di comandante o di capo mi disse: “Joe, se la finisci di scassare la minchia fino allo sbarco ti do un pacchetto di sigarette e una bottiglia di Cabernet”. Lo riconobbi subito il mio dialetto, quel bastardo era un siciliano. Sarei potuto essere “felice”… se avessi “calato” le corna, ma gli risposi: “chef, io non bevo e neanche fumo! io ti rompo le corna a te e a quella grandissima lorda di tua madre”. Svariati calci con la punta delle sue scarpe mi colpirono la bocca e la faccia, e, contemporaneamente, gli altri energumeni mi massacrarono di pugni sulla schiena e su qualsiasi altra parte del mio corpo sempre alla loro mercé. Figli di troia.
Non avevo lacrime da versare, non avevo muscoli da riuscire a muovere, non avevo una cellula del mio giovane corpo che fosse integra. Sentivo un ammasso enorme che mi soverchiava, provocandomi sofferenze lancinanti, quasi rantolavo, ossia ansimavo tout-court.
Qualche ora dopo quel “capo” entrò coi suo scagnozzi nella cella, si avvicinò al letto e mi disse affettuosamente: “testa di minchia, come stai?”. Io risposi: “chef, portami stu vinu e li sicaretti ca nun ci la fazzu mancu a tradurri”. Mi sorrise ed esclamò: “lo sapevo che alla fine saresti stato un ragazzo pulito e diligente, ora te li porto”. I sottoposti rimasero nella cella, la porta aperta, e dopo qualche minuto quel gradasso tornò davvero con una bottiglia di vino e le sigarette. Volle bere insieme a me e ordinò ai tirapiedi di aiutarmi ad alzarmi. In piedi davanti a lui sorrisi e scattai in uno spastico saluto militare e sull’attenti. Lui versò il vino in due bicchieri, me ne porse uno, e superbo, tronfio, vittorioso esclamò: “paesa’, alla nostra e alla Sicilia!”. Sorrisi e gli diedi una testata sul naso, abbattendolo e gridando: “paesa’, a quella bagascia di to matri!”. Fine della mia boria…
La nave giunse in rada e dopo una mezz’ora cominciarono le operazioni di attracco.
Tre militari mi accompagnarono in bagno, mi diedero un asciugamano persino pulito. Mi sciacquai delicatamente il viso tumefatto, gli occhi gonfi e strapazzati denotavano chiaramente pugni stampati alla rinfusa. Stavo a pezzi.
Mi scortarono in cella, sul letto vidi mutande, calzini, anfibi, una tuta mimetica verde, non era policroma ma almeno all’apparenza sembrava seminuova, e come per incanto… un paio di occhiali da sole. Mi avrebbero parzialmente protetto le iridi castane con bordo verde, nascosto malamente i segni di quel viaggio di piacere.
Salimmo in coperta, io con le mani dietro la schiena ma senza manette. Uno mi precedeva e gli altri due mi seguivano da dietro. Lassù ad attendermi c’era lo chef col naso adunco rotto…
Era un uomo coi capelli neri, sembrava un corvo, basso e tarchiato, una specie di minotauro inespressivo. Mi chiese: “allora, la vuoi ‘sta sigaretta?”. Presi quella “schifezza” dal pacchetto che mi porse. Lui me l’accese e cominciai a fumare, a tossire, ma mi rilassò come una canna.
Guardai il mare, gli edifici, le case che si scorgevano da quel ponte scoperto.
Una luce nel cielo mi ristorava e riscaldava, riportandomi in vita dopo giorni passati in un inferno che sapevo essere di breve durata. Una potente emozione mi incantava, respirando quell’aria salubre, fresca e soprattutto viva.
Era un istante felice.
Joe Oberhausen-Valdez
VISITA I NOSTRI PRODOTTI SU AMAZON