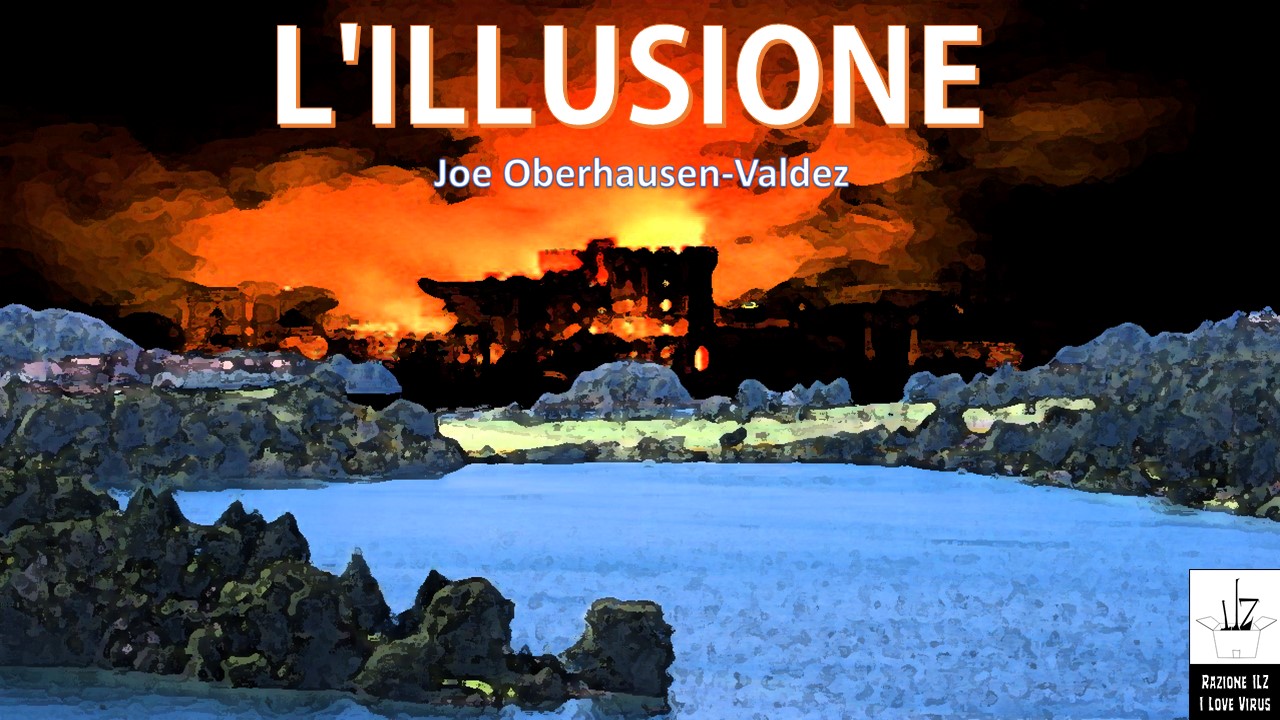La zia aveva comprato da poche settimane una casa in campagna, distante qualche chilometro dal paese. La costruzione era in realtà un rudere, che abbisognava di varie ristrutturazioni, che lo zio, in pensione da anni, avrebbe iniziato ad eseguire nella primavera ormai prossima.
Il terreno che circondava le quattro mura era abbastanza esteso, ricco di alberi di ogni sorta, alberi mai visti prima; attrasse la mia attenzione un’enorme quercia, dai rami vigorosi e ombrosi. Da uno di questi scendevano due corde che si abbracciavano ad una tavola: un’altalena.
Un bimbo avrà un tempo goduto di quel passatempo, di quello spazio, di quell’aria fine e silenziosa, di lunghe corse attraverso il verde smisurato di una collina che degrada chissà dove.
Ora invece era un posto per vecchi.
Alla fine dell’estate la zia sarebbe andata in quiescenza; io non ce la vedevo proprio a fare la spola dalla casa del paese alla campagna; mi sembrava strano che lei, che amava viaggiare in terre lontane, si fosse decisa all’acquisto di una residenza villica. Eppure così avvenne.
Del resto in età matura si capisce qualcosa di più, forse si cambia tutto quel che si era.
La gioia della partenza, per ristorarsi in posti oltre un qualsiasi oceano oppure oltre la periferia del proprio borgo, è pur sempre un’illusione dalla quale si ritorna più stanchi di prima. Il vero benessere è solo nella propria tana.
Dopo svariate telefonate, mi decisi a visitare la campagna. Avrei mangiato sicuramente bene.
Lillo iniziò a sciorinare tutti i suoi progetti, mentre camminavamo in quel posto meraviglioso, conducendomi in giro tra gli alberi, le pietre, lo steccato del nuovo orto.
Ci fermammo in uno spazio, in cui stazionava possente e immobile un escavatore giallo. Lo zio mi disse che in quel punto sarebbe sorto un laghetto di tre metri di larghezza e trenta di lunghezza, che ci avrebbe portato dal mare la sua barca a motore, che avrebbe riempito l’acqua di trote, che lui avrebbe pescato come un pescecane tra l’ampio respiro del profumo di quel verde, immerso nella quiete che aveva sempre sognato.
Sì, è vero, non c’erano le onde e nemmeno il vento della sua Linosa, ma in compenso avrebbe risparmiato benzina, seppur sarebbe mancata la varietà del pesce. Sempre trote.
A me la trota faceva schifo, quindi non sarei mai andato a pescare con lui, nel lago. Adoravo invece il tonno, però al massimo in quello stagno avrebbe potuto allevarlo come scatolette.
Lo zio era un uomo eccezionale, creativo e geniale. Mi guardò, quasi sorrise, e mi disse; “non ti preoccupare, quando la struttura sarà pronta, potrai pescare pure il tonno. Fidati di me!”.
L’estate folgorava le pendici, le colline, le cime del monte in cui avevo la fortuna di abitare. Il giardino odorava di nuovi alberi da frutto, di una ventina di nuove mimose, che avevo piantate in inverno, sperando che crescessero velocemente, sino a divenire alte, rigogliose, largendo profumo e ombra, a me, che le avrei guardate e ammirate come emblema della natura che ammanta il vivere.
Le ciliegie polpose e dolcissime mi si scioglievano in bocca, nonostante io fossi parco nel coglierle, ancorché avido del loro sapore. Ma erano purtroppo poche, apparse per miracolo da quelle piante al momento giovani e piccole.
In mezzo a quell’eden non sembrava vero che al di là della mia regione, oltre lo stretto e persino ancor più lontano, nel continente, ci fosse un’epidemia o una pandemia che decimava intere città o regioni. A me chiaramente interessava ben poco, perché l’evento accadeva in un posto in cui non sarei andato.
Lassù, quegli uomini forse stavano esagerando, forse impazzendo; l’isteria era esplosa all’improvviso, trascinando quelle menti in un’atmosfera irreale, in preda all’ossessione della morte e del contagio. Osannavano la propria rabbia, quasi come cani randagi, bavosi, che mordono qualsiasi cosa si trovi per la loro strada: legni, pietre, incudini.
Strillavano contro l’inefficienza del governo, la disorganizzazione della Sanità, del mondo che si sarebbe arrestato col crollo del nord industriale, locomotiva economica dello stato. E minchiate varie.
Non volevano la quarantena, i locali chiusi; invocavano le metropolitane funzionanti, le fabbriche e gli uffici aperti. Al postutto, volevano continuare a essere macchine utensili, perché la libertà da tutta quella routine li soffocava. Erano ormai prigionieri della propria dimora, e inutili corpi in una vita senza scopo, senza l’allucinogeno che mena dritto alla vecchiaia.
Come sarebbero sopravvissuti?!
Osservavo il mare, seduto su un tronco di pino, che avevo modellato a forma di panca. Tutto attorno a me, fuggevole e incantevole, aveva la placidità di ciò che è immenso e immutabile.
Al di là di quel paesaggio, di questa vista sublime, al di là di questo tempo, non vedevo cambiamenti e ansie, non presagivo croci, non mi dilaniava il tormento o la speranza.
Il sole sorgeva dietro la roverella, piantata da mio padre, e tramontava oltre le due colline, piantate da Dio.
Poi non c’era più niente.
Calava la sera, come ogni sera, scendeva l’umidità da un cielo fisso, si adagiava sulle larghe foglie del fico, fluendo lentamente come le lacrime di uno che non vuole piangere.
A cento metri dal fico si stagliava il cancello che nonostante le parti ossidate era ancora splendente nel suo verde color bosco. Mi sembrò, lassù, di intravvedere due figure, quindi corsi per la salita fino a quelle parvenze che parlavano come vive.
Mi avvicinai a loro e attraverso l’inferriata sentii, nauseante, la bocca avvinazzata di lei, laida e spaventosa come una strega, che, un tempo forse bella, chiedeva da mangiare. L’uomo si era seduto con le spalle al muro in calce, russava, o rantolava.
Il mio diniego fu inteso come un dileggio. A quel punto la donna, inveendo e gridando, quasi latrando, cercò di arrampicarsi su per il cancello, ma non vi riuscì. Mi sedetti lungo il viale, aspettando i prossimi eventi, ma non ve ne furono.
Albeggiava, quando mi accorsi che due cani malati agonizzavano davanti al cancello. La notte precedente, ebbro, non mi ero accorto che quei due cristiani fossero in realtà due quadrupedi.
Tornai a casa e mi distesi sul divano accanto alla stufa spenta.
Nella stanza c’erano già ventotto gradi centigradi. Faceva caldo dentro e fuori.
Le colombe tubavano assordanti e odiose. Erano sfuggite alla trappola che avevo installato tra il tetto della casa e il pino sul quale volteggiavano insopportabili. La macchina di morte era semplice: due fili di ferro a due centimetri di distanza, tesi, ma senza toccarsi, in ciascuno dei quali scorrevano il positivo e il negativo della corrente di casa. Ebbene, finora le bestie erano state fortunate. Il salvavita le aveva amnistiate.
Il giorno dopo avrei collegato i due fili al gruppo elettrogeno, senza salvavita, che quindi non avrebbe avuto pietà. Erano sopravvissute, ma era un’illusione, la speranza era solo un ritardo del destino, o il tempo esatto per il loro dissolvimento. Se fossero state mute, sarebbero sopravvissute.
Di pomeriggio il telefono squillò senza risparmiarmi. Risposi alla zia che mi invitava per il pranzo di inaugurazione della villa di campagna, di domenica, un sacrificio che non potevo rifiutare.
Il viaggio durò circa due ore, come sempre, tra le valli, le colline arse e desolate di quelle tre province prettamente arabe che costituiscono l’entroterra arida e sperduta della mia isola. Non si arrivava mai a destinazione.
Era come se fosse un percorso alla deriva. Ritornavo al passato, e ogni volta ne volevo sempre uscire, quanto prima. Quanto più celermente possibile da quel mondo, riflesso di una giovinezza che ritrovavo con le sembianze di un anziano. Tornare in quei luoghi mi faceva sentire più vecchio di come non fossi, più prossimo alla fine di quanto non credessi. Poi, uscito da quella dimensione, mi risvegliavo vivo nel presente, o almeno così credevo.
La zia venne ad aprire il cancello, murato a una ventina di metri dalla casa.
Entrando, vidi i sorrisi festosi di mia madre e di altri parenti, ma non scorsi lo zio. Era a pescare nel suo lago.
Dopo un caffè, due chiacchiere, tre tirate di pipa, mi diressi verso il vecchio, attraversando il prato a destra dell’albero dell’altalena. Dalla collinetta vidi la barca che navigava verso il nord dell’enorme cisterna. Quando arrivava al piccolo molo, lo zio invertiva la rotta.
Raggiunsi l’attracco a sud, l’uomo, calvo e basso, da una pancia prominente riempita negli anni specialmente di pasta, mi vide e arrestò il motore, gioioso e festante, facendomi segno di salire a bordo. Dopo i convenevoli, riaccese il motore e ripartimmo verso nord. A metà delle acque arrestò l’imbarcazione, si sedette e lanciò il filo della canna da pesca giù nel torbido di quella melma.
La trota che apparve tirata su dal mulinello era grandiosa, e lo zio felice. La ripose in una cesta, dicendomi che avrei potuto pescare anche io, il tonno se avessi voluto, o lo sgombro o il pescespada. All’inizio non compresi come potessero vivere in quello stagno di acqua dolce pesci prettamente di mare; lo zio mi illuminò, quando mi porse una canna da pesca modificata, che non terminava con un amo ma con una pesante e grossa calamita.
Sul fondale giacevano varie tipologie di pesci in scatoletta, che il vecchio marinaio aveva buttato dentro diverse settimane addietro. L’idea mi piacque. Avrei catturato una bestia a me gradita.
Buttavo la lenza con la calamita in acqua a più riprese, mentre lo zio andava su e giù per il lago con la barca, ciononostante, dopo un’ora di andirivieni, non pescai nulla. Forse erano troppo pochi i barattoli, oppure mi aveva preso in giro. In ogni caso gli suggerii di acquistarne un centinaio, anche duecento o trecento scatolette, perché dal nord della penisola arrivavano cattive notizie, quelle dell’epidemia che pian piano stava allargandosi in tutto il paese, contagiando senza pietà.
Una riserva di pesce, là sotto, in quello stagno sarebbe potuta essere una dispensa occulta e importante. Certamente la difficoltà era nel recuperare le provviste solo con l’ausilio della canna col magnete, ma con una buona maschera, scendendo in apnea si poteva attingere più agevolmente alla scorta.
Lo zio sorrise, dicendomi: “sai che non ci avevo pensato?! Domani comprerò pesce di ogni sorta.”.
Tornammo a casa. Il pranzo era pronto. La zia ci aveva avvertiti gridando, schiamazzando, come si usa fare in quel paese, anche da una distanza di centinaia di metri.
Quella notte avrei dormito nella mansarda, dove c’erano un letto e un tappeto logoro che Clotilde (il nome della zia) mi aveva portato per il mio cane; gli zii in una camera matrimoniale non ancora rifinita, e mia madre in una stanzetta, che un tempo era un ripostiglio, senza finestra, che adesso sembrava davvero una cella.
L’alba giunse presto, dileguando l’oscurità del silenzio estivo in pochi attimi.
Scesi a far colazione, scese pure il cane, che subito corse fuori.
Iniziò ad abbaiare. Lo vidi girare attorno ad un camioncino stracarico di alimenti. Il tetto del veicolo ne pullulava. Perché latrava, pure contento, con la bava alla bocca?! Lo compresi avvicinandomi al mezzo. Lo zio, per aumentare la dispensa, aveva comprato ogni tipo di lattine: fagiolini, piselli, trippa, e per sicurezza anche scatolette per cani, perché nella sua testa, se un quadrupede domestico poteva mangiare quel vitto, anche un cristiano se ne sarebbe potuto servire.
Il cane riconobbe la marca delle sue lattine, e quindi vi girava attorno, come per dire: “roba mia, roba mia.”.
Lo zio era quasi impazzito col timore di questa epidemia, pandemia, o semplice influenza che fosse, ormai delirante e dissennato pure lui, offuscato come tanti, come troppi, dal timore della morte, della malattia, e ancor di più dall’angoscia di poter crepare di fame, prima che per mano sanguigna di qualche virus.
Cosa accomunava un uomo qualsiasi del sud a un uomo del nord industrializzato? Forse la paura di avere troppa libertà, di non essere una macchina semovente, una morsa da bancone, uno che va e viene con la metropolitana per decine e decine di anni, consumando la sua unica esistenza nel muovere una leva, fare una o col bicchiere, seppellirsi in un ufficio?! No.
Lo zio era in pensione, e quella liberazione dal lavoro la gustava giorno per giorno come un uomo che finalmente si dedica alla propria indole, alla propria vita, a sé stesso.
Avrebbe pescato, anche durante l’apocalisse, vera o presunta, mentre al nord avrebbero rimpianto quella pena che ogni mattina e ogni sera conduce alla decomposizione.
L’affrancamento non è un’aspirazione dello schiavo.
Il solo legame tra lo zio e l’uomo del nord era appunto il timore della morte, e né l’uno né l’altro si avvedevano che essa era dentro di loro fin dal parto. Erano nati per morire, non per pescare, per costruire piramidi, per viaggiare tra i continenti a bordo di macchine volanti.
In una vita senza scopo, l’unica felicità sarebbe stato l’attimo, ma in quell’istante avresti dovuto mangiare, poiché non c’è un piacere superiore di quel momento in cui hai fame e mastichi un nutrimento.
Ecco perché la gente svuotava i supermercati, facendo scorte straordinarie. Aveva ansia, l’ossessione che non potesse più trovare edifici in cui comprare. A quel punto le sarebbero rimaste solo poche scelte: crepare di fame, aspettare un vitto dal governo, andare a caccia di qualche bestia, buttarsi alla cieca in qualche campo alla ricerca di frutti. Avrebbe dovuto vivere come l’animale che era un tempo. Non era una potenzialità per tutti.
Aiutai lo zio a buttare le scatolette nel lago. Quando il lavoro fu compiuto era già sera, tornammo a casa per cenare e ristorarci con qualche bicchiere di vino dall’arsura patita e dal sudore versato per scaricare tutte quelle vettovaglie dal furgone.
Mentre divoravamo la salsiccia cucinata alla brace, sentimmo voci che provenivano dal cancello, qualcosa che grattava il ferro, forse unghie che s’infrangevano sulla lamiera.
Uscimmo fuori. Il buio riempiva la campagna di un’ombrìa glaciale, e a poco valeva la luce di alcuni lampioni sparsi malamente nel vasto terreno. Distinguemmo solo il groviglio di braccia che si accalcavano alle colonne di cemento armato tentando di varcarle, altre di svellere la rete circostante.
Quelle bocche gracchiavano sofferenti, e non erano becchi di corvi.
Tutta la strada era invasa da una folla derelitta, un’onda che si trascinava miserabile, lamentosa, un ammasso di malati, che procedeva senza meta. Il virus era mutato.
Joe Oberhausen-Valdez